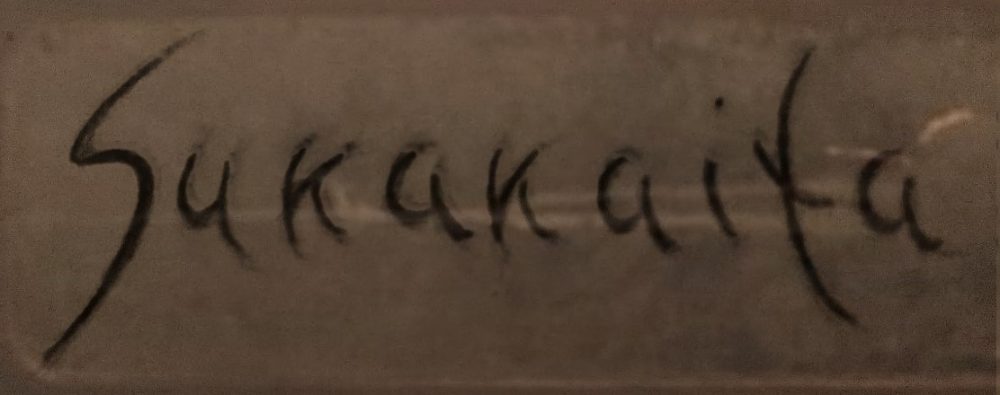Orapronobis
Scritto da Paolo Randazzo
Ci si emoziona il doppio, in questa estate che segue al lockdown e alla conseguente, dolorosa, chiusura dei teatri, se ci si trova ad assistere  non già a un lavoro purchessia, a qualcosa che dia un segno di speranza e ripartenza (che già non è poco), ma di fronte a uno spettacolo teatrale vero e proprio: vero per l’autenticità della concezione e della scrittura, vero per l’intensità della messinscena e della prova d’attore. È quanto si è visto il 25 luglio scorso, nel contesto delle Orestiadi di Gibellina (alla trentanovesima edizione e ancora guidata da Alfio Scuderi), con lo spettacolo “Orapronobis” scritto e diretto da Rino Marino e interpretato da Fabrizio Ferracane. Drammaturgia, regia e interpretazione che si dispiegano integralmente nel ruvido e tagliente dialetto siciliano di Castelvetrano. Diciamo subito che si tratta di un lavoro interessante per la concezione e per le tematiche e che l’interpretazione di Ferracane, generosa e totalmente all’altezza della difficoltà del testo, sa restare vigile nell’evitare ogni possibile caduta nel patetico o nel pittoresco. Dapprima a dispiegarsi sulla scena (spoglia, oscura, illuminata per squarci e con sensibilità pittorica) è una richiesta di ascolto e di giustizia: un anonimo povero cristo (con alle spalle un’esile croce e un Cristo spezzato) si rivolge, umiliandosi, a un prelato impassibile, senza pietà, silenzioso, distante (è un manichino stilizzato, appoggiato su una sedia). Chiede ascolto e chiede senso, ma riceve la protervia di un silenzio disumano. È difficile dire quanto consapevolmente, ma sembra riproporsi, ribaltata, la situazione della dostoevskiana “Leggenda del grande inquisitore” (da ricordare anche nella versione teatrale di Peter Brook): in questo caso però è il silenzio del prelato la lingua del potere mentre, al contrario, è il (povero) cristo a protestare il proprio umanissimo (e quindi totalmente divino), lacerato dolore. Nella seconda parte si ripercorre la vicenda oscura e torbida di un delitto perpetrato da Mumino (Mumminu), un bambino ritardato, fratello del protagonista, che uccide, strangolandolo, un altro bambino che lo canzonava. Un episodio che spinge indietro nel tempo il protagonista. Una vicenda oscura, un delitto improvviso, inconsapevole e inspiegabile, una ferita non rimarginabile anche nell’esistenza del narratore. Un evento che spinge improvvisamente e brutalmente a riflettere sulla fragilità della nostra vita, sul senso della morte nella vita, sulla durezza e sull’impotenza del potere, sul senso della morte che non è affatto una vecchia strega (una “ddraunara”, con una meravigliosa parola scavata nella storia più antica del dialetto), che non viene con la falce. No: la morte è un bambino pallido e con gli occhi incavati che gioca innocente a nascondino e corre e va cercando in ogni angolo le sue vittime, mentre tutti gli scappano davanti e provano invano ad evitarlo; ma quando esclama “T’ho visto”, allora è finita, è finita ogni festa. È straordinaria la densità poetica di questa immagine che da sola vale il testo intero. Quando la morte ti raggiunge non c’è giustizia da pretendere o tempo per trovar rimedi, non c’è ragione da far valere: la vita ripiomba nel mistero e in quel silenzio tirannico e doloroso che è molto più che mancanza di parole. Lo spettacolo si chiude ad anello: una nuova dislocazione temporale, un breve cenno di saluto a quel prelato silenzioso e impietoso che s’era visto prima. Una chiusura netta che apre voragini di senso e illumina ulteriori giacimenti di teatro e bellezza.
non già a un lavoro purchessia, a qualcosa che dia un segno di speranza e ripartenza (che già non è poco), ma di fronte a uno spettacolo teatrale vero e proprio: vero per l’autenticità della concezione e della scrittura, vero per l’intensità della messinscena e della prova d’attore. È quanto si è visto il 25 luglio scorso, nel contesto delle Orestiadi di Gibellina (alla trentanovesima edizione e ancora guidata da Alfio Scuderi), con lo spettacolo “Orapronobis” scritto e diretto da Rino Marino e interpretato da Fabrizio Ferracane. Drammaturgia, regia e interpretazione che si dispiegano integralmente nel ruvido e tagliente dialetto siciliano di Castelvetrano. Diciamo subito che si tratta di un lavoro interessante per la concezione e per le tematiche e che l’interpretazione di Ferracane, generosa e totalmente all’altezza della difficoltà del testo, sa restare vigile nell’evitare ogni possibile caduta nel patetico o nel pittoresco. Dapprima a dispiegarsi sulla scena (spoglia, oscura, illuminata per squarci e con sensibilità pittorica) è una richiesta di ascolto e di giustizia: un anonimo povero cristo (con alle spalle un’esile croce e un Cristo spezzato) si rivolge, umiliandosi, a un prelato impassibile, senza pietà, silenzioso, distante (è un manichino stilizzato, appoggiato su una sedia). Chiede ascolto e chiede senso, ma riceve la protervia di un silenzio disumano. È difficile dire quanto consapevolmente, ma sembra riproporsi, ribaltata, la situazione della dostoevskiana “Leggenda del grande inquisitore” (da ricordare anche nella versione teatrale di Peter Brook): in questo caso però è il silenzio del prelato la lingua del potere mentre, al contrario, è il (povero) cristo a protestare il proprio umanissimo (e quindi totalmente divino), lacerato dolore. Nella seconda parte si ripercorre la vicenda oscura e torbida di un delitto perpetrato da Mumino (Mumminu), un bambino ritardato, fratello del protagonista, che uccide, strangolandolo, un altro bambino che lo canzonava. Un episodio che spinge indietro nel tempo il protagonista. Una vicenda oscura, un delitto improvviso, inconsapevole e inspiegabile, una ferita non rimarginabile anche nell’esistenza del narratore. Un evento che spinge improvvisamente e brutalmente a riflettere sulla fragilità della nostra vita, sul senso della morte nella vita, sulla durezza e sull’impotenza del potere, sul senso della morte che non è affatto una vecchia strega (una “ddraunara”, con una meravigliosa parola scavata nella storia più antica del dialetto), che non viene con la falce. No: la morte è un bambino pallido e con gli occhi incavati che gioca innocente a nascondino e corre e va cercando in ogni angolo le sue vittime, mentre tutti gli scappano davanti e provano invano ad evitarlo; ma quando esclama “T’ho visto”, allora è finita, è finita ogni festa. È straordinaria la densità poetica di questa immagine che da sola vale il testo intero. Quando la morte ti raggiunge non c’è giustizia da pretendere o tempo per trovar rimedi, non c’è ragione da far valere: la vita ripiomba nel mistero e in quel silenzio tirannico e doloroso che è molto più che mancanza di parole. Lo spettacolo si chiude ad anello: una nuova dislocazione temporale, un breve cenno di saluto a quel prelato silenzioso e impietoso che s’era visto prima. Una chiusura netta che apre voragini di senso e illumina ulteriori giacimenti di teatro e bellezza.
C’è soltanto un aspetto di questo lavoro che non convince, o non convince del tutto, un aspetto che merita un supplemento di riflessione: si tratta dell’uso del dialetto. Ovviamente nulla questio sulla liceità di questa scelta, sulla sua potenzialità poetica e qui – deo gratias – la neolingua di Vigata proprio non ha casa e non sembra benvenuta: ciò che non convince è un certo automatismo per cui ancora oggi, nei nostri anni del 2000, in Italia e in Sicilia si sceglie di scrivere in dialetto un testo di teatro, e per giunta di grande densità poetica, senza interrogarsi sul perché profondo di questa scelta e, soprattutto, senza far sì che questa domanda, semmai si sia presentata alla consapevolezza del drammaturgo, diventi essa stessa parte attiva della drammaturgia e dello spettacolo. Proviamo a spiegarla in un altro modo questa aporia: quella di Pasolini sulla natura e sulla funzione poetica, e quindi politica, del dialetto è una lezione insuperata e ancora viva, ma proprio per questo non va applicata automaticamente. Il dialetto dovrebbe restare ingrediente (centrale) di una più complessa, attuale ed eloquente lingua teatrale che va oltre il dato meramente linguistico e si mostra come indice di riflessione culturale e di un’urgenza poetica, politica o esistenziale tali da pervadere l’intero spettacolo. Un’urgenza critica che in questo caso, seppure nella potenza e nella profondità di senso di questa creazione teatrale, si stenta a intravedere.
ORAPRONOBIS
Di Rino Marino, regia di Rino Marino. Con Fabrizio Ferracane. Assistente di scena Gianluca Giambalvo e assistente scenografo Liborio Maggio. Effetti sonori di Rudy Pusateri e Antonio Bonanno.
Voci off di Annamaria la Barbera, Cristina Perrone, Ermelinda Palmeri. Produzione Ass. Cult. Sukakaifa. Spettacolo finalista Premio Rete Critica 2014. Il testo di Orapronobis è compreso in Tetralogia del dissenno (Editoria&Spettacolo 2020).
Crediti fotografici: Salvino Martinciglio